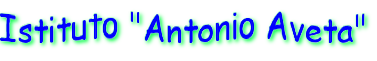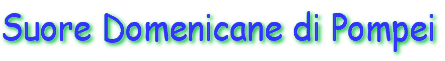Bartolo Longo scrittore
*B.L.e l'emarginazione sociale *B.L.scrive alle Sr.del Quilici *B.L.scrive salmi e prega *La penna e il Rosario *Nel 1900 il Giubileo di B.L. *Pensieri scelti fra gli scritti del B.B.L. *Preghiere di B. L. *Passato e Presente *Rosario e Eucaristia: il Cielo sulla terra! *Sant'Apollonia in un testo del B. B. L.
*Bartolo Longo e l'emarginazione sociale, con particolare riguardo ai figli dei carcerati
Premessa: Fede e Carità, prospettiva unica nell'azione di Bartolo Longo.
(…) Da tutti gli atti e le parole di Bartolo Longo, balza nettamente evidente la chiara coscienza di essere depositario, in tutta umiltà di un messaggio grandioso da lanciare al mondo del XIX e del XX secolo.
Senza fermarci sugli aspetti analitici di tale missione : diffusione della devozione alla Vergine del Rosario, risveglio della fede, richiamo al soprannaturale, senso della Chiesa, vigorosa azione sociale e caritativa ecc., vogliamo qui cogliere e sottolineare l’unitarietà profonda di ogni sua iniziativa che poggiava su un principio basilare che diverrà anche la nostra chiave di lettura del suo impegno verso il mondo degli emarginati:
"Dio voleva che noi, un semplice ed ignoto laico, in nome della Madonna parlassimo a tutto il mondo; voleva che fossimo un araldo della carità ed insieme un banditore della fede".
Ed esplicita:
"La Vergine non ama la fede in Lei senza le opere di carità. A questo scopo pensammo compiere ogni atto di fede nostra, con un’opera di carità. È questo possiamo dire, il palpito più sentito del nostro cuore".
Fede e carità si integrano e si illuminano a vicenda; costituiscono per Bartolo Longo un binomio indissolubile: "L’opera di Valle di Pompei , come spesso abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo, è sorta, e si è ingrandita costantemente come una magnifica epopea di Religione insieme e di Carità, di fede e di Beneficenza educativa. Le opere della Fede sono state sempre preludio di nuove manifestazioni di religione e di culto".
Non è solo il mondo della povertà a cui andare incontro con provvidenze e soluzioni economiche; è il mondo più vasto e complesso dell’emarginazione sociale, della carenza di affetti, di dignità, di prospettive di senso della vita a cui Bartolo Longo si apre.
Vedremo come il suo strumento di intervento non sarà tanto la beneficenza materiale, quanto "curare il male alla radice", ricercare e affrontare le cause piuttosto che fermarsi a tamponare momentaneamente gli effetti.
Per questo l’azione di Bartolo Longo si rivolgerà prevalentemente all’educazione, alla riabilitazione, al ridonare consapevolezza e dignità, ad offrire gli strumenti idonei per uscire definitivamente da una situazione negativa.
A – la vicenda
Innanzi tutto è da sottolineare che l’idea di un’opera così nuova ed impegnativa si è fatta strada nella mente di Bartolo Longo, vincendo forti dubbi e resistenza interiori.
"Senza che noi ci fossimo accorti, senza nessuna personale intenzione nostra, l’Opera già era nella mente di Dio" afferma riferendosi all’anno 1887; anzi confessa realisticamente, commentando il casi del bambino della detenuta Maria Grazia Iandiorio che cercavano di affidargli: "Se io non aveva pensato giammai al Figlio dei Carcerati, tanto meno il mio pensiero poteva rivolgersi a bambini di pochi mesi o di pochi anni, che appena avevano lasciato il latte materno. Confesso che fino al quel momento non avevo avuto mai inclinazione a bambini; anzi per me un fanciullo era una noia indescrivibile, e pensavo quale difficoltà avessero avuto i miei educatori per educare me; ma per bambini così piccoli non avevo mai avuto un pensiero. Risposi immantinente che non era possibile per parte mia fare alcun bene a quella madre sventurata, che io compativa assai, ma che non poteva consolare in alcuna maniera. Se fosse stata almeno una bambina io facendo pur eccezione alle regole stabilite nel mio Orfanotrofio circa l’età di ammissione, l’avrei contentata. Ma un maschio? … dove l’avrei collocato?... come l’avrei allevato io, che solamente aveva aperto da poco un’altra camerata di orfanelle, una seconda schiera e non aveva che giovani maestre?... ma di uomini? Neppure parlarne. E credevo con un no reciso tutto essere finito; ma non era così scritto nei decreti della dolcissima Provvidenza di Dio".
Quando il 24 maggio 1891, ormai superate tutte le titubanze, dettava allo stenografo sotto il titolo "Un voto del mio cuore", il suo progetto di azione in favore dei figli dei carcerati, un lungo cammino interiore si era compiuto; in questo faticoso itinerario prendevano ormai un chiaro posto provvidenziale vicende e interventi molto disparati dagli ultimi cinque anni, a prima vista totalmente slegati tra loro, ma tutti concorrenti a maturare in lui la coscienza di un problema gravissimo e ancor più la consapevolezza che proprio lui era chiamato ad affrontarlo.
In questo documento, che segna la nascita morale dell’opera, già Bartolo Longo sintetizzava tutti i punti salienti del problema e del progetto:
– la fonte: "La carità di Cristo, che è fuoco vivo, intende a dilatarsi sulla terra e non guarda confini".
– la mediatrice: "La Regina della Misericordia… che ci aveva messo in cuore la santa risoluzione di sposare al culto la beneficenza";
– l’umile realismo: "La Un voto segreto del nostro animo, che da tempo chiudiamo gelosamente nel cuore con una perplessità, a volte dolorosa, la quale nasce dal desiderio ardente di attuarlo, e dall’evidente insufficienza e, direi quasi impossibilità dei mezzi, per venirne a capo";
– i destinatari: "I fanciulli più abbandonati… che sono in condizione peggiore degli orfani, che portano senza colpa il marchio dell’infamia… senza educazione e senza freno… che fra poco si daranno al vizio, e quindi al delitto";
– la finalità: "L’educazione morale e civile dei figli di carcerati" che di riflesso "è altamente benemerita della civiltà e della patria: dopodiché eserciterebbe anche, nel medesimo tempo un’azione altamente educativa e moralista delle Carceri e dei Bagni di pena";
– la novità: "è questa un’opera cristiana tutta nuova, di cui ad oggi non vi ha esempio né in Francia, né nel Belgio, né in altre cattoliche nazioni: L’Italia sarebbe la prima a possederla".
A – L’idea centrale.
Era un progetto ambizioso.
Di fronte alle affermazioni positivistiche egli proponeva il suo grande atto di fede che resterà sempre l’idea centrale dell’opera: "Queste disgraziate creature, affermano i positivisti, sono dalla nascita fatalmente predestinate a percorrere tutta la nefasta via della delinquenza, e nessuna prevenzione al mondo, nessuna educazione potrebbe trattenerle dall’incamminarsi fatalmente per la via della colpa e del delitto. Queste dure e scoraggianti affermazioni, che si circondavano della falsa luce di scienze positive e di dati sperimentali, non solo non ci trattennero dall’ardua impresa, ma non ci impressionarono neppure: noi non credevamo all’onnipotenza del male, noi credevamo invece alla forza redentrice del bene, all’efficacia rinnovatrice dell’educazione. A misura, perciò, che la pubblica inesauribile carità ne forniva i mezzi, io raccolsi quanti fanciulli potei, Figli dei Carcerati, e curai che fossero educati secondo un metodo speciale".
"Potei dimostrare, con l’eloquente prova dei fatti, che anche i fanciulli, i quali per disgrazia atavica hanno ereditato un’istintiva propensione a delinquere, sono suscettibili di un’educazione che ha la forza di correggere, modificare, e qualche volta di distruggere quella inclinazione naturale, quasi trasfusa nel loro sangue dai padri e dagli avi".
È la chiara affermazione della fede nell’uomo e nella sua libertà spirituale e della forza redentrice e formativa dell’educazione.
Questa è l’idea centrale su cui poggia l’impresa educativa di Bartolo Longo.
B – I mezzi pedagogici.
Il primo, fondamentale, è il lavoro, intenso, da Bartolo Longo sia come strumento formativo nel periodo che i ragazzi passano nell’Istituto, sia come mezzo che assicura il reinserimento sociale dignitoso dopo il termine di tale periodo.
Il tema del lavoro ritorna molto spesso nelle pagine di Bartolo Longo per le sue molteplici implicazioni di tipo formativo, sociale, ecc. In una ci offre una sintesi del suo pensiero su questo tema, affermando: "Il lavoro, secondo la nostra scuola, è essenzialmente educatore".
Strettamente collegato con il lavoro è lo studio, di cui Bartolo Longo aveva una personale visione, confacente alla particolare situazione a cui doveva far fronte; per i suoi ragazzi non prevedeva tanto lo studio come accademico ornamento intellettuale, ma piuttosto come mezzo per rendere più umana, efficiente ed adeguata la preparazione professionale.
"L’educazione non deve essere, com’è stata finora, intesa solamente ad istruir la mente, senza aver d’occhio la vita, ma a contemperare la cultura della mente con quella del cuore, il sentimento del dovere, e la legge del lavoro; il tutto sostenuto, vivificato dalla religione, la quale solleva l’anima al cielo e le impedisce di sprofondare nella materia, che la uccide e snatura".
Bartolo Longo aveva ben chiare le caratteristiche educative della musica: "Nel mio metodo educativo è di grandissimo momento il frammezzare la fatica del mestiere, o l’esercizio delle arti meccaniche con lo studio della Musica, e con l’apprendere l’arte degli strumenti musicali e con il suonare in concerto. In generale la Musica è per me un elemento dei più rilevanti per la educazione di questa classe di fanciulli. E però la Musica, nella quale questi già cominciano a progredire notevolmente, è entrata nel vasto complesso educativo, onde è frutto il singolare buon andamento dell’Ospizio, perché così suggerivano la Pedagogia e l’esperienza.
La pedagogia m’insegnava quali frutti di disciplina, di ordine, di armonia nel volere e nell’operare derivano dall’ affiatamento e dalla simultaneità che sono necessari in una Banda musicale".
Infine, come altro mezzo pedagogico altamente valorizzato da Bartolo Longo troviamo l’educazione fisica, coordinata con le altre attività: "Ho prescelto a mezzi ausiliari di educazione per monelli lo svolgimento delle forze fisiche e muscolari, come la ginnastica e gli esercizi militari, il salto, la corsa e i bagni".
C – I mezzi morali e spirituali.
Non per nulla il suo binomio inscindibile era "lavoro e preghiera". Certamente, l’aspetto morale – spirituale costituisce il nucleo centrale di tutta la sua concezione educativa e rappresenta anche un suo personalissimo tocco di originalità nell’applicazione alla particolare situazione dei figli dei carcerati. La base di tutto il lavorio educativo dev’essere un altro elemento, che i primi due coordini, li stringa in un vincolo indissolubile, e sia loro di sostegno incrollabile e di vita, che non venga mai meno.
Questo nuovo elemento, che è la vita essenziale dell’educazione, è la Carità. Solo quando sono ispirati, animati, guidati, e come vivificati dalla carità, quei due fattori di Educazione e di Civiltà riescono nello scopo, e producono quegli effetti durevoli e proficui che tanto si desiderano. "La parola Carità, come l’intendo io, e con me milioni di uomini sapienti, legislatori e benefattori veri dell’umanità, siccome la intende tutto il Cristianesimo, vuol dire amore: ma non amore di sé, non amore interessato, non terreno, non basso e volgare; ma sì invece nobile, amore puro, amore divino; quell’amore che ebbe sede nel Cuore del divin Redentore, e del cui fuoco Egli vuole sia accesa la terra; quell’amore parte da Dio e a Dio ritorna, e nel cammino abbraccia e involge le creature, e segna di un’orma fiammeggiante di beneficenza la via che percorre dalla terra al cielo".
Tutto questo complesso di interventi, e la carità stessa che li ispirava, facevano però capo al mezzo educativo principe per Bartolo Longo, cioè la religione.
"Io non seguo, nella scelta di questi fanciulli e nel metodo di educarli, né la scuola della Salpetrière, né quella di Nancy, né il Lombroso, né il Ferri, né questo o quell’altro scienziato. Capo – scuola italiano o straniero, che è Cristo".
d – La sintesi finale: il "segreto" educativo di Bartolo Longo.
Mezzi pedagogici, accorgimenti psicologici, formazione religiosa ed ogni altro strumento educativo trovano la loro sintesi unitaria e suprema in quello che Bartolo Longo amava definire il "suo segreto", il suo mezzo educativo infallibile: l’incontro con Gesù Cristo.
Il sistema di Bartolo Longo è, infatti, "cristocentrico" ante litteram. Basti, per sottolinearlo, qualche rapido brano scelto tra le tante ardenti pagine sull’argomento che costellano i discorsi e le trattazioni sull’educazione dei figli dei carcerati; non hanno bisogno di alcun commento.
"Ecco venuto il momento, in cui vi svelo apertamente il mio segreto. Esso non è nuovo, ma è stato messo disuso, come roba rancida, che non confaceva al progresso dei tempi. Ma io non temo le risa beffarde degli increduli o il sorriso ironico di chi, riputandosi scienziato positivista, ha rinnegato tutto un nobile passato, cioè l’eredità della sapienza e del senno pratico dei padri nostri per inventare e spacciare teorie che non hanno solido fondamento. Non temo tutto ciò, e sono ardito di evocare principi didattici, oggi gittati da canto e spregiati dai moderni cultori della pedagogia. Né le mie saranno semplici asserzioni: vi racconterò fatti e vi presenterò statistiche, poiché pare che la statistica valga oggi più che ogni altro argomento. E senz’altro vi dico, che il mio Segreto è nella nota fondamentale dell’armonia dell’universo, in quella nota arcana che vibra nel cuore dell’uomo, che fa beato chi ne ascolta la melodia, che è l’essenza e la pietra angolare della vita e del progresso dell’umanità.
Quella nota che esiste e armoniosamente freme per tutti, e che pure tanti considerano come spenta per sempre; quella nota fondamentale di ogni bellezza, di ogni civiltà, di ogni benessere sociale è Gesù Cristo.
Così ho fatto io per i figli dei carcerati. La loro educazione si diceva difficile, per motivi impossibili; il loro avvenire si prevedeva tristissimo: ed io ho fatto vibrare in quei cuori innocenti la nota che vi ho detto. Loro ho presentato, loro ho fatto amare Gesù Cristo"…
Conclusione
Sono cento anni da quando Bartolo Longo iniziò a raccogliere la prima schiera di fanciulli pompeiani per il catechismo; sono cento anni che il suo grande cuore continua a battere per chi soffre, all'unisono con il Cuore del suo unico Maestro: "Senza Cristo potremo avere noi una vera carità? Ah! Una sterile compassione, sì; parole di conforto, sì; ma i fatti, i fatti! Chi ci fa raccogliere questi fanciulli? Chi ci fa amare il figliuolo della vittima dei malfattori? È Cristo. Chi ci fa amare il figliuolo dell’assassino? È Cristo. È Cristo che fa sorgere qui una città nuova sotto gli auspici della civiltà nuova; è Cristo che ha ispirato me, povero uomo. Cristo è legame universale, potente, benefico, sociale. Senza Cristo non vi è legame, non amore, non carità, non beneficenza. Togliete Dio, avrete una sterile compassione, ma amor vero, caldo, efficace, duraturo, non mai".
Ecco il segreto che Bartolo Longo grida ancora!
(Da: il R.n.P. del 1982 – n° 7-8 – Autore: Mario Presciuttini)
*Bartolo Longo scrive alle Suore del Quilici
Nell’archivio romano delle Figlie del Crocifisso ci sono tre lettere inviate da Bartolo Longo alla Superiora Generale di queste religiose, fondate da Giovanni B. Quilici (Documenti della fondazione, filza Sacerdoti vari).
Questa religiosa, Suor Matilde Fantini, aveva scritto al Beato, ma nell’archivio di Pompei non esiste traccia delle sue lettere, il cui tenore però può essere dedotto dalle risposte del Longo, che portano l’intestazione: Avv. B. Longo, dir. Del periodico Il Rosario e la Nuova Pompei e degli Asili infantili pompeiani.
La prima porta la data "Valle di Pompei, 8 gen. 1887" e dice: "Osservatissima Suora, Compio di buon grado il suo desiderio, spedendole non pure i quattro fascicoli ora chiestimi, ma eziandio il mio periodico gratuitamente. – Il triduo di preghiere, per Lei e per tutte le sue consorelle, comincerà domani. – Mi creda con osservanza – Suo Umilissimo Bartolo Longo".
La seconda lettera porta la data del 9 febbraio 1887 e recita: "Rev.ma M.re Superiora. Mi è pervenuta la sua preg.ma lettera, e la ringrazio delle gentili espressioni. – Tenga pure il periodico per lo passato, ma le raccomando di propagare la divozione del S. Rosario, con questa carta devozione avremo sempre e grandi grazie. – Gradisca i miei ossequi e pure lei preghi pel – suo dev.mo – Avv. B.L. – ".
La terza è datata 1° maggio (1887). Lascia intendere che la scrivente attraversa di difficoltà. Il Beato la rassicura di aver dato "scrupolosa esecuzione" ai desideri di lei e soggiunge che farà pregare i bambini pompeiani secondo le di lei intenzioni ed augura che la Madonna del Rosario "voglia benignarsi di esaudire completamente i suoi desideri".
Ringraziando per le 10 lire che la religiosa livornese gli aveva inviate.
(Autore: Res)
*Bartolo Longo scrive Salmi e Prega
Il primo Convegno storico su "Bartolo Longo e il suo tempo", celebrato a Pompei nel maggio 1982, ha ben messo in luce l’ampia produzione letteraria longhiana, sempre finalizzata all’educazione civile e religiosa dei lettori: gli opuscoli, volumi e volumetti, il periodico "Il Rosario e la Nuova Pompei", attestano il fecondo risultato di una felice vena di scrittore, ma anche del rimatore ispirato, sensibile in modo privilegiato alla bella forma poetica e letteraria del Salmo biblico, che egli parafrasa con rispetto e maestria. Il Longo mostra di avere fra le mani e di consultare ogni giorno il libro sacro dei Salmi. Se ne avvale per la propria spiritualità, per l’esortazione degli altri, per offrire motivazioni solide ai problemi che va esponendo, per persuadere circa le soluzioni che per essi propone. Ed intanto, quasi insensibilmente, ne riveste il ritmo, ne penetra le assonanze, ne assorbe la forza logica del parallelismo, ne assapora il gusto della proclamazione e della recitazione orante. La preghiera in salmo diventa così nello spirito del Longo e nella sua proposta educativa un eccelso momento di vita religiosa, di relazione con Dio, di rapporto interessato per i fratelli.
Il lettore delle opere longhiane può quindi essere ben certo di trovare forza e serenità allo spirito, sprone per le situazioni della vita quotidiana nelle ben riuscite parafrasi di trasmessi. I Salmi biblici esposti in parafrasi dicono quanto don Bartolo rimanesse affascinato da questo Genere Letterario della poesia ebraica che, nel suo ritmo cadenzato, gli permette di cantare e celebrare le lodi di Maria con pieno svolgimento dei temi voluti, suggeriti da meditazione religiosa, ma ancor più dalla condizione dell’uomo e della mole dei concreti problemi che sempre lo inseguono e l’accompagnano.
Il Cantico di Maria (Lc 1,45-56) nella parafrasi di B. Longo.
Merita una specifica menzione il prezioso opuscoletto "Cinque Salmi al Nome benedetto della Vergine del Rosario di Pompei" (Pompei 1896). Il primo dei cinque è il Cantico di Maria, pregevole risultato di prolungata meditazione della Vergine sulla sua chiamata a dare compimento in sé al "ministero" di Madre del Figlio dell’Altissimo (Lc 1, 35). La elaborazione di B. Longo, che considera con la dovuta attenzione il testo dell’evangelista Luca, ce ne offre una parafrasi "situata": la "situazione" della nascente opera in Valle di Pompei cioè, fatta di uomini e di cose, svolge un ruolo primario nella elaborazione poetica e letteraria del cantico mariano. Ben marcato e non esagerato è anche, e ovviamente, la descrizione del profilo ministeriale di Maria, quale risulta da una attenta sia pur sintetica analisi della parafrasi longhiana.
Eccone il testo:
4. Grande e gloriosa la fece Colui che è possente, * e il cui Nome è santo e terribile.
5. Egli l’avvicinò a sé con un miracolo della sua onnipotenza, * e con la sua grazia la fece onnipotente, cooperatrice col Figlio alla salvezza del mondo.
6. La costituì Mediatrice presso il nostro Mediatore, * Rifugio e rimedio a tutti i nostri mali.
7. Ella partorì la Misericordia, * e Iddio diede a Lei l’ufficio di Avvocata dei peccatori.
8. E la sua misericordia passa di generazione in generazione, * sopra coloro che la onorano.
*La penna e il Rosario
Bartolo Longo fu un versatile scrittore. Aveva la penna facile anche per un santo non è una dote necessaria. La sua esigenza era quella di realizzare una forma di comunicazione vasta e moderna da far conoscere la Nuova Pompei. La città e le opere diventavano così esse stesse un fatto, una notizia. Una grande notizia per la Chiesa e per il Mezzogiorno.
Aveva la penna facile. Per un santo non è forse una dote necessaria. Per un santi fondatore, forse sì. Per un Santo fondatore come Bartolo Longo, scrivere era come segnare la corona del rosario.
Intensa la preghiera, appassionata e anche ricca di foga la scrittura. Due funzioni certamente diverse, ma mettere mano alla penna era come allungare il raggio di quella dolce catena che doveva legare insieme – come poi fu – il Santuario, la comunità intorno e le prime Opere che i mattoni della carità ponevano a base della Nuova Pompei.
Pochi altri strumenti oltre la penna – e qualche rotativa spinta dai fiumi d’inchiostro che l’allora fiorentissima stampa cattolica mandava avanti – potevano consentire di ampliare il raggio d’azione alle iniziative e alle attività intraprese.
Dio sa se ce n’era bisogno, perché l’originalità della Nuova Pompei, la santa follia di Bartolo Longo, era non solo quella di costruire un Santuario, ma appunto di farvi vivere intorno una città. Una città di Maria, un popolo del rosario.
La santità non ha certo bisogno di farsi largo a colpi di pubblicità, e d’altra parte, il bene – per diffondersi – ha sempre saputo trovare le sue strade.
Ma l’esigenza di Bartolo Longo non era certamente quella di porre sotto i riflettori un’intuizione dello spirito, bensì quella di realizzare una forma di comunicazione tanto vasta e moderna da orientare su tutta la Nuova Pompei le antenne di un nuovo e mirabolante interesse.
La città e le opere diventavano così esse stesse un fatto, una notizia. Una grande notizia per la Chiesa e per il Mezzogiorno. Un evento autentico, intorno al quale l’informazione andava in qualche modo a "informarsi" per essere poi in grado anche di formare.
È dalla linearità di questo percorso che emerge, successivamente, anche la prospettiva dell’adeguamento dei mezzi.
Pioniere, Bartolo Longo lo è stato in tutti i campi. E anche nella complessa – e allora difficilissima – realtà dei mass-media ha finito per lasciare il segno, arrivando ad anticipare, finanche, alcune figure professionali che soltanto la complessità dei tempi di oggi lascia emergere.
Bartolo Longo fu giornalista, ma non solo: fu editore, stampatore, propagandista, diffusore e riuscì a pregustare in qualche modo una forma di comunicazione del tutto nuovo: quello di press-agent di promotore non solo delle Opere ma della conoscenza di ciascuna di esse.
L’occasione fu la visita a Pompei dei congressisti della stampa internazionale riuniti a Napoli nell’aprile del 1899. Bartolo Longo volle che i giornalisti passassero per Valle di Pompei "per mostrare loro la gloria della religione, dell’Arte e della Carità italiana".
Era l’11 aprile 1899.
La visita è descritta minuziosamente dai giornali dell’epoca. L’Avvocato dell’Ospizio per i figli dei carcerati volle che i giornalisti visitassero personalmente la realizzazione sociale che aveva fatto maggiormente parlare i giornali e la stampa dell’epoca soprattutto per i riflessi scientifici che aveva destato.
Moltissimi fogli, artisticamente inquadrati tra cornici e fregi, con la scritta bicolore "Souvenir de la Visite de Messieurs les Publicistes du Congrés de la Presse a l’Hospice de Fils des Forcats ed à in Valles de Pompei" furono posti all’ingresso dell’Ospizio perché i giornalisti potessero apporvi la loro firma.
Furono messi anche a disposizione quattro interpreti. Bartolo Longo, pensando che tra i congressisti non sarebbe certamente mancato un considerevole numero di cattolici, fece preparare seicento pacchetti con corone, medaglie, immagini, racchiuse in piccole buste insieme a libri e opuscoli sull’Opera di Pompei.
C’erano molti giornalisti stranieri e un qualificato gruppo di giornalisti italiani tra i quali: Matilde Serao, Alfredo Fortes de "Il Mattino", Raffaele Tudisco, Salvatore Di Giacomo, Nicola Misasi de "Il Corriere di Napoli", Vincenzo Carli del "Roma", Adolfo Ricciardi del "Diavolo Rosso", Pasquale Dumont de "Il Paese", Raffaele Ferrara Correra della "Libertà", Anna Kuliscioff ed Andreina Kuliscioff, Giacomo Pastore del giornale "Osservatore Cattolico" ed altri.
Quel giorno suonò la banda musicale dell’Ospizio. I giornalisti visitarono il Santuario, l’Orfanotrofio, i laboratori e la scuola tipografica.
"Noi stessi facevamo da guida a quei che potevamo – ricorda Bartolo Longo in un resoconto pubblicato su "Il Rosario e la Nuova Pompei" – e da un gruppo passavamo all’altro, più a lungo si trattenne in questo esame ed in questa visita la dottoressa Anna Kuliscioff, la signora che un cocente dolore affligge e tormenta. Erano con lei la figliola Andreina Costa Kuliscioff.
Quest’ultimo capitolo ci presenta Bartolo Longo in veste appunto di un efficiente press-agent ante litteram, animato da una fede profetica e che non guardava solo ad un risanamento spirituale e morale bensì a tutto ciò che tale programma avrebbe potuto suscitare nell’opinione pubblica se ampiamente pubblicizzato. Press-agent, quindi, ma tutto al servizio di Pompei e delle Opere.
Quanto a se stesso, se c’era una cosa che detestava era la pubblicità alla sua persona, le "piaggerie" che talvolta gli venivano rivolte anche a mezzo stampa e che lui metteva da parte, come materiale senza valore.
Sintomatico un suo commento a un articolo apparso sulla "Gazzetta di Mondovì" nel quale si parlava dei "segreti di un novello Don Bosco".
"Non vale molto. È una lode a me".
Se proprio vi era spinto per i capelli, e ritenendo di poter contribuire alla migliore conoscenza della Nuova Pompei, si lasciava talvolta intervistare, ma prestando sempre molta attenzione alla scelta delle fonti.
Era molto attento alla lettura dei giornali il più delle volte preferiva abbonarsi o che alcuni devoti zelanti gli facevano pervenire. Sottolineava e chiosava a margine, con la sua tormentata scrittura, giudizi e commenti sugli articoli che più direttamente riguardavano la sua opera.
C’è da immaginare che buona parte della sua giornata Bartolo Longo la dedicasse alla lettura della stampa che cominciava ad interessarsi sempre più spesso di Valle di Pompei quando l’Opera dei Figli dei Carcerati divenne un punto di riferimento per la critica criminologica. Comprendeva il ruolo della stampa nel clima di fervente rinascita della stampa cattolica napoletana che "con i suoi pregi e difetti costituisce una interessante testimonianza di un’epoca, di una cultura saldamente ancorata ai principi tradizionalisti; di correnti che in tutti i modi allora possibili rappresentarono, bene o male, la forza della conservazione del vecchio Stato napoletano riluttante a sparire e a confluire nello Stato unitario".
Scenari che appartengono davvero ad altri tempi. Ma la modernità di Bartolo Longo traspare anche nel suo rapporto con i mass-media, tanto che viene da pensare a cosa metterebbe mano oggi, il fondatore della Nuova Pompei, per comunicare non solo all’Italia, ma al mondo il messaggio di una città che continua a vivere intorno al Santuario della Vergine.
Altri giornali? Una radio? La televisione? Una rete multimediale? Il collegamento via Internet?
Forse tutte queste cose insieme.
Ma una su tutte: "l’attualità e la modernità del messaggio".
È questo il vero capofamiglia di tutta la famiglia dei mass-media.
Gli strumenti sono certamente importanti, ma decisivo resta il contenuto. E su questo piano la Nuova Pompei continuerà a restare nuova per sempre.
(Autore: Angelo Scelzo)
*Nel 1900 il Giubileo di Bartolo Longo
Pellegrini da ogni parte del mondo arrivarono nella capitale della cristianità per il Giubileo indetto da Papa Leone XIII. Molti facevano tappa anche nella città di Maria. Il fondatore del Santuario parla di quell'evento eccezionale nelle pagine de "Il Rosario e la Nuova Pompei".
"Straordinarie benedizioni di Dio son discese in questi giorni con un numero ancora straordinario di grazie e di miracoli della nostra cara Madre la regina del santo Rosario. È un accorrere inusitato di Figli suoi, che pellegrinando a Roma per guadagnare il Giubileo, fanno termine del loro viaggio questa Valle di prodigi, rende questo suolo di misericordie, questo santuario mondiale e pontificio il convegno dei cuori del mondo, il punto della terra privilegiato, ove si pregusta la pace del Paradiso".
Sembrano parole scritte oggi, nel corso dell’Anno Santo della Misericordia, ed invece sono parte di un articolo che il Beato Bartolo Longo scrisse nel primo numero de "Il Rosario e la Nuova Pompei del 1900. Papa Leone XIII aveva indetto il Giubileo agli inizi del secolo che sarà definito "breve", segnato dai due grandi conflitti mondiali che semineranno milioni di morti e distruzione ovunque. Non era l’Anno Santo "diffuso" voluto da Papa Francesco, non si erano aperte le Porte sante in ogni diocesi del mondo, Roma e le sue basiliche erano la meta unica dei pellegrini.
Eppure migliaia di persone giungevano a Pompei per fare visita a Maria Santissima. Così racconta il Longo giornalista: "I primi pellegrinaggi recatisi ai piedi dei Santi apostoli nella Città santa, prima di far ritorno ai loro paesi, alle loro case, sono venuti a salutare la madre comune che tanti benefici ha arrecati alle famiglie, alle città, al mondo intero per il corso mai non interrotto di un quarto di secolo. E chi può dire le attitudini devote, il fervore delle preghiere, gli slanci di una carità tutta celeste di che in questi giorni ci hanno offerto esempio preclaro e sacerdoti e secolari, e signore e donne del popolo, che dai più lontani luoghi d’Italia sono venuti in pie comitive, in lunghi pellegrinaggi a provare in questo Santuario quel che noi da anni dicevamo, e non da tutti ancora creduto, gaudii di Paradiso, pace di Paradiso?". I pellegrini giungevano da ogni parte: tanti dal Piemonte, dalla Lombardia, dal territorio genovese, ma finanche dalle "gelide Alpi" e dalla "remota Valle d’Aosta". Non si trattava, allora, di viaggi comodi o brevi.
Con una nota di evidente soddisfazione il Fondatore del Santuario annotava: "Alcuni capi dei pellegrinaggi piemontesi ci assicuravano che non pochi del popolo, invitati a far parte del pellegrinaggio a Roma per guadagnare le Sante Indulgenze, dicevano: "Noi verremo a Roma, purché ci conduciate a vedere la Madonna di Pompei". La citazione spiega la diffusione e la profondità della devozione alla Vergine.
È interessante leggere, tra le pagine di quel numero del nostro Periodico, come Bartolo Longo parlasse della quotidianità dell’Anno Santo in Santuario: "Mai non sono interrotte le pratiche di pietà e di religione che nello splendore del culto e nella bellezza delle armonie dei suoni e dei teneri canti fanno di questa Valle un lembo di Paradiso". Ma per avere il perdono dei peccati occorre tra l’altro un’opera di carità che testimoni la conversione del cuore. Quest’aspetto è stato reso centrale da Papa Francesco, che non si stanca mai di richiamare al soccorso dei più deboli.
Nel paragrafo intitolato "Come si santifica l’Anno Santo in Valle di Pompei", il Beato cita l’esempio della marchesa Dusmet Girardi che da Napoli inviava un "involto" di biancheria "accompagnato" da una lettera: "La pregherei – chiede al Longo – di voler avere la carità di provvedere delle tre camicie e tre paia di calze, una poverella, un poverello e un bambino". Era diffusa, soprattutto nel Sud Italia, la tradizione di donare il "pranzo ai tre poveri" in prossimità delle feste dedicate alla sacra Famiglia e a San Giuseppe. I poveri dell’oggi incarnavano Gesù, Maria e Giuseppe che non trovavano riparo se non un un’umile mangiatoia di Betlemme o, ancora, esuli in Egitto.
Al Longo basta questa breve missiva per rendere l’importanza della carità fatta di piccoli gesti d’attenzione e condivisione. Per il resto la santificazione dell’Anno giubilare si concretizza nella celebrazione della festa della Sacra famiglia, nel mese di marzo dedicato a San Giuseppe, nella preghiera dei quindici sabati che anticipano la ricorrenza solenne dell’8 maggio, nella continua recita del Santo Rosario, nelle novene, soprattutto nelle celebrazioni dell’Eucarestia. A ben vedere sono appuntamenti che scandiscono sempre la vita del Santuario e prescindono dal Giubileo. Si potrebbe quasi dire che a Pompei la gioia dell’Anno Santo è perenne e va oltre la sua durata.
Scrive a proposito il Beato: "Mentre il mondo va a Roma per santificare questo che è l’ultimo anno del secolo decimonono, da Roma il mondo viene a Valle di Pompei dove perenne è la festa delle anime, continuo è l’irraggiamento delle grazie divine che dal Trono sacro alla regina delle Vittorie si emana ad allietare i figli della Croce: In questo Santuario la festa dell’amore filiale versa la più tenera delle madri è continua; mai non sono interrotte le pratiche di pietà e di religione che nello splendore del culto e nella bellezza delle armonie dei suoni e dei teneri canti fanno di questa Valle un lembo di Paradiso".
Ma in quel 1900 un evento straordinario ci fu: la festa per i venticinque anni dall'arrivo del Quadro della Madonna del Rosario a Pompei. Un giubileo nel Giubileo. Celebrata il 7 ottobre, il Beato ne parlerà come di "apoteosi dell’Immagine Taumaturga Pompeiana" e, da cronista di razza, racconterà dei quarantamila accorsi ad accompagnare l’Icona in processione lungo le strade cittadine, dei gonfaloni e delle bandiere provenienti da tutto il mondo come segno di partecipazione, della selva di fiori, dei canti, della musica, dei "salve" dell’artiglieria per omaggiare colei al cui nome si rallegrano i cieli.
*Pensieri scelti fra gli scritti del Beato Bartolo Longo
“Pompei… preziosa eredità dell’uomo venerando che, pur vivendo nel secolo si fece apostolo di fede e di carità con Opere meravigliose che si impongono all’ammirazione del mondo”. (PIO XI)
Presentazione: IL Santuario della fratellanza
Il Fondatore del Santuario, delle Opere annesse e della nuova città di Pompei. Un Giurista sottile ed acuto che lottò strenuamente contro le teorie positiviste in voga a quel tempo in tutte le università d’Italia, d’Europa e del mondo. Un vero rivoluzionario dell’antropologia criminale.
Un sociologo cristiano che con animo di pioniere realizzò la dottrina sociale della Chiesa contenuta nella memorabile enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Il costruttore delle prime case operaie in Italia, sorte a Pompei nel 1887. Un Profeta delle speranze eterne.
Un apostolo travolgente che riuscì con i suoi scritti a suscitare un movimento mariano di dimensioni mondiali e propagò il Rosario nei cinque continenti. Un missionario della pace che, presago degli immani conflitti incombenti sull’Europa sul mondo nel ventesimo secolo, indisse un plebiscito per la pace universale. Due volte infatti fu posta la sua candidatura per il premio Nobel per la pace e non fu accolta perché la sua era Opera religiosa. Un asceta che visse in unione con Dio e che ancora oggi, pone in ginocchio davanti a Maria, due volte all’anno, tutta la Chiesa nell’ora della Supplica: l’”Ora del mondo”, come amò definirla. Uno strenuo difensore del Papa e della Chiesa.
I suoi ideali: la Madonna, il Rosario, i giovani, l’Eucaristia, il Papa.
La Fede
Ridestare la fede in quei che l’hanno perduta, renderla operosa in quei che la posseggono inerte, ecco il compito affidato a quanti si son posti a propugnare l’azione religiosa dei popoli.
* La Fede, o pio lettore, è il primo dono che io ti auguro da Dio, cioè quella fede operosa e perfetta, che rendeva i nostri santi, che sono i veri primogeniti nostri fratelli, altrettanti leoni nel confessare Gesù Cristo, nel predicare il Vangelo, nel difendere la Chiesa, nell’esprimere in sé la pratica dei divini insegnamenti.
* Ora il mezzo più facile e più efficace e nello stesso tempo più acconcio a tutte le condizioni dell’uman genere per conservare la Fede nelle proprie famiglie, ci vien porto dalla stessa Madre di Dio nel suo Santo Rosario.
Ecco il segno certo della nostra finale vittoria.
* Per noi la Chiesa è come il centro di luce che spande i suoi raggi benefici ad illuminare il retto cammino che deve far la civiltà. Il ricco e l’indigente, l’artigiano e l’agricoltore, il giornaliere e il commerciante, il popolo insomma che assorge ad incivilimento, al lume della fede che gli viene dalla Chiesa, diventa naturalmente morale.
La Fede e l’Amore: la fede in Gesù Cristo e l’amore alla Vergine Maria.
La Carità
Pompei: meraviglia della Grazia
E che avrebbe attirato l’attenzione e l’affetto del sommo Capo di tutta la criminalità da sospingerlo a dichiarare suo il Santuario di Pompei, rendendolo Pontificio sotto l’immediata giurisdizione del successore Pietro?
* Un giorno, correva l’ottobre del 1872, la procella dell’animo mi bruciava il cuore più che ogni altra volta e m’infondeva una tristezza cupa e poco men che disperata. Uscii dal casino De Fusco e mi posi con passo frettoloso a camminar per la valle senza saper dove. E così andando, pervenni a lungo più selvaggio di queste contrade, che i contadini chiamavano Arpaja, quasi abitacolo delle Arpie. Tutto era avvolto in quiete profonda. Volsi gli occhi in giro: nessun’ombra di anima viva. Allora mi arrestai di botto. Sentivami scoppiare il cuore. In cotanta tenebria di animo una voce amica pareva mi sussurrasse all’orecchio quelle parole, che io stesso avevo letto0 e che di frequente ripetevami il santo amico dell’anima mia, ora defunto: - Se cerchi salvezza, propaga il Rosario. È promessa di Maria. Chi propaga il Rosario è salvo! – Questo pensiero fu come un baleno che rompe il buio di una notte tempestosa. Satana, che mi teneva avvinto come una preda, intravide la sua sconfitta e più costringeva nelle sue spire infernali. Era l’ultima lotta, disperata lotta. Con l’audacia della disperazione, sollevai la faccia e le mani al cielo, e rivolto alla Vergine celeste: - Se è vero – gridai, - che Tu hai promesso a S. Domenico, che chi propaga il Rosario si salva; io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo Rosario. Niuno rispose: silenzio di tomba mi avvolgeva dintorno. Ma da una calma che repentinamente successe alla tempesta dell’animo mio, inferii che forse quel grido di ambascia sarebbe un giorno esaudito.
Una lontana eco di campagna, giunse ai miei orecchi, e mi scosse: sonava l’Angelus del Mezzodì. Mi prostrai e articolai la prece che in quell’ora un mondo di fedeli volge a Maria. Quando mi levai in piedi, mi accorsi che sulle guance era corsa una lacrima. La risposta del cielo non fu tarda.
È la Madre dei miseri e dei peccatori che qui aperse il fondo delle sue misericordie.
La Vergine Maria
Premessa ai pensieri del Beato Bartolo Longo su "La Vergine Maria"
Nella solenne cerimonia di beatificazione in Piazza San Pietro del 26 ottobre 1980, Giovanni Paolo II definì Bartolo Longo come "l'uomo della Madonna". Diversi decenni prima lo stesso Bartolo Longo postillando un libro di G. Croiset (G. Croiset - Esercizi di pietà, in Opere Complete, Livorno 1846, vol. VII, pag.261), si chiedeva: "Qual'è la mia vocazione? Scriver di Maria, far lodare Maria, fare amare Maria". E Stefano De Fiores nel 1982, sfatando luoghi comuni, rivendicava per il Fondatore di Pompei il primato dell'editoria mariana (De Fiores S. - Maria nell'esperienza e negli scritti di Bartolo Longo, in Bartolo Longo e il suo tempo. Atti del Convegno storico promosso dalla Delegazione Pontificia per il Santuario di Pompei sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica "Pompei, 24-28 maggio 1982 -, a cura di F.Volpe, Vol.I pag.137, Edizione di Storia e Letteratura, Roma 1983). Ma chi è Maria per Bartolo Longo?
La Vergine di Nazareth è "la sintesi della fede in Dio e dell'amore per il prossimo", è "la pienezza delle Grazie. É la prima figura ritratta dal Dolfino di Napoli sulla primitiva deforme e lacera Immagine della Vergine del Rosario.il Santuario di Dio, il paradiso di Dio". Questa sua intima, personale e straordinaria identità traccia e determina conseguentemente la sua esperienza terrena nel rapporto con Dio e con gli uomini: "O Maria, voi veniste al mondo colma di meriti per colmare il mondo di felicità e di benedizioni. Voi nasceste per divenire la Madre di Dio e per essere la madre degli uomini, la Signora suprema degli uomini, nostra speranza, nostro assillo, nostro rifugio, nostra consolazione". Per questo motivo Maria è la "pietra angolare del grande edificio spirituale". Perché legata profondamente a Cristo, suo Figlio e suo Signore, è anche "specchio senza macchia che riflette l'immagine del Verbo umanato. Tu sei un ritratto prezioso senza errori di tutta la Santità di Lui".
Perciò è beato "chi ama Maria! E più beato chi notte e giorno ascolta i consigli di Lei, ed ogni giorno eleva il suo cuore a Dio". Maria "Tempio animato del Dio vivente, ... eletto trofeo delle divine magnificenze" e a Pompei "calamita dei cuori", "tesoro di pace a chi la invoca in vita, pegno di vittoria nel passo estremo", "Madre benigna di tutta l'umanità". Nel 1926, quasi come testamento spirituale del suo amore per Maria, il Beato scriveva:" Invoca Maria! Il suo nome non si levi mai dal tuo labbro, non mai si parta dal tuo cuore. Seguendo Maria non ti perderai. Se pensi a Maria, non fallirai. Se ti tieni stretto a Maria, non cadrai. Se Maria ti protegge non potrai temere. Se Maria ti guida non ti stancherai. Se Maria ti soccorre certamente arriverai al cielo".
La Preghiera
In quel momento solenne per noi, le preghiere degli altri, le preghiere dei nostri Fratelli, in virtù delle promesse infallibili di Cristo, ci otterranno la grazia della perseveranza finale, ossia la vittoria decisiva.
* Quando voi non vi accorgete della distrazione, essa non sarà una distrazione di cuore. Appena che ve ne avvedrete, alzerete gli occhi verso Dio. La fedeltà che avrete nel rimettervi alla presenza di Dio, ogni volta che vi accorgerete del vostro strato, vi meriterà la grazia di una presenza più frequente; questo è il mezzo di rendere ben presto familiare questa presenza.
Il Rosario
* Nella preghiera del Rosario sono città intere, masse di popoli diverse per lingue, per razza, per colore, per costumi, che si fondono insieme in un medesimo luogo, in un’ora medesima, in uno stesso concetto, in un medesimo affetto, in un canto unisono di benedizioni alla benedetta fra le Madri, alla Vergine delle grazie, alla Madre dei peccatori.
La consegna di Bartolo Longo
Raccomando a voi questo Santuario. Con quell’amore con cui l’avete edificato, finitelo, custoditelo, accrescetelo.
Raccomando al vostro cuore queste Orfanelle e questi Figli dei carcerati che insieme abbiamo salvato.
Sotto lo scudo della Madonna di Pompei, ed ai raggi benefici della vostra carità, quelle e questi si educhino al bene, all’onestà ed al lavoro; e con la vostra carità cresca ogni dì il numero dei beneficati salvando tanti altri fanciulli derelitti e miseri.
L'incontro con Dio
* Sceglieva dei peccatori a strumento di questa Opera sua, forse perché con essa doveva salvare altri peccatori, e forse perché un peccatore così favorito dalla misericordia di Maria avesse a riaccendere nel cuore di altri peccatori la speranza e l’incoraggiamento di trovare ugualmente la divina misericordia.
* Sì, ogni anima che si salva accresce la gloria di Dio in Cielo.
Il Santuario
Pensieri del Beato Bartolo Longo su "Il Santuario"
I Carcerati
Pensieri del Beato Bartolo Longo sui "Carcerati"
Le preghiere hanno la loro storia, e vengono, il più delle volte, suggerite da speciali condizioni storiche e spirituali. Così fu per le preghiere di Bartolo Longo.
Più lucente apparirà il “messaggio” che la Madonna ha voluto affidare al suo Cavaliere fedelissimo, e che il Santuario gelosamente conserva, sviluppa e trasmette.
Bartolo Longo scrittore ed oratore mariano
Bartolo Longo scrisse e parlò molto della Madonna. Lo giurò e mantenne l'impegno. Lo giurò nell'ottobre del 1872, testimoni il cielo e la terra, mentre le campane del mezzogiorno cantavano alla Madre di Dio tutto l’amore umano e tutta la confidenza di figli.
Bartolo Longo tenne per ben cinquant’anni questa "cattedra", e la sua produzione "impegnata" si faceva, di anno in anno, sempre più elaborata ed acclamata. Non scrosci di mani egli chiedeva o cercava, non applausi alla sua persona, ma che le mani di tutti gli uomini, ed i cuori e le menti, si congiungessero a sciogliere inni alla Regina del Santo Rosario. Pare che, scrivendo in onore della Madonna, avesse avuta ognora presente e viva, la visione della mistica rosa del paradiso di Dante. Lo amò difatti come poeta e come cantore della Vergine Madre; senza mancare di citarne ora una terzina, ora un verso. Se volessimo raccogliere tutti gli articoli e le preghiere composte in onore della Vergine, ne verrebbe fuori un bel volume: un volume interessante e, forse, il più ricco di qualunque lume: un volume interessante e, forse, il più ricco di qualunque altro che si possa pensare composto, finora, intorno alla teologia mariana in genere, e sul Rosario in specie. Comunque sarebbe la prima opera del genere composta da un "laico".
Se Bartolo Longo fosse vissuto ai nostri giorni, dopo che il Concilio Vaticano II ha chiamato i laici, ufficialmente, all’impegno cristiano ed alla partecipazione dei problemi intimi della Chiesa, avremmo sentito echeggiare la sua voce – che era, come attestano tanti, armoniosa e piena di pathos – nell’aula conciliare. Di quanti interventi si sarebbe fatto promotore, e con quanto calore avrebbe sollecitato, egli, i Padri Conciliari, mentre discutevano il capitolo VIII della Costituzione intorno alla Chiesa! E quanto avrebbe esultato nel sentire esaltato il Santo Rosario e il titolo di "Madre della Chiesa" dato alla Madre di Dio!
Del resto il suo tema obbligato era la Madonna; vista, studiata ed amata attraverso le luminose finestre o i cieli festosi e ridenti del Santo Rosario. Così lo svolse egli il Rosario e lo cantò in tanti anni di attività, di ansie, di gioie, di amarezze. Lo sentiremo ugualmente, forse con più efficacia, attraverso le sue preghiere, le più appassionate e le più note e popolari in tutto il mondo. Egli ormai è un "classico" del Santo Rosario. Nessuno lo ha meditato e presentato con quella fede e con quello slancio come lo visse, lo presentò e lo presenta ancora a chi lo recita, a chi viene nel Santuario, a chi visita i suoi Istituti. Ma… un fatto ci addolora. Sono pochi quelli che parlano di Bartolo Longo, secondo la storia. Tanti ne conoscono il nome in una luce inesatta. Nelle enciclopedie si fa apparire la sua figura assai sfocata, in uno dei tanti luoghi comuni: un avversario della Chiesa, un mezzo gaudente che, tocco dalla grazia, finisce per convertirsi, ed, a prova del ritorno alla fede, erige una chiesa e fonda due Istituti per gli Orfani d’ambo i sessi: Orfani della natura e della legge… Meridionale autentico, vissuto a Napoli, dopo i vent’anni, diventa "napoletano" anche nelle sue manifestazioni religiose… e napoletano, per questi critici, vale: ampolloso, ampio, caricato… Così è giudicato… da non pochi, perché non sanno, ma dovrebbero documentarsi. Della sua Opera così illuminata e penetrata dal miracolo non tutti ne fanno parola. Bartolo Longo, sotto vari aspetti, i migliori, è ancora da scoprire. Ed uno degli aspetti più interessanti è quello "teologico"; e diamo alla parola tutta la sua carica.
Egli non è il pietista facile a sciogliere inni ed a mettere insieme frasi ed invocazioni "raccogliticce", per diffonderle e creare la rèclame al "suo" Santuario ed alla Immagine da lui stesso battezzata con il nome di "Nostra Signora del Rosario di Pompei…" e gli Orfani che sono uno specchietto per impietosire e raccogliere offerte. Gli Orfani sono un vero Rosario vivente attorno al Trono della Vergine, angioletti… umani. Le offerte costituiscono la sensibile assistenza e presenza della Madonna nella sua Casa "Pompeiana", casa sorrisa da poveri bimbi, i quali nell’amore alla Regina del Cielo confortano l’orfanezza e ritrovano la vita, alla quale, come ogni uomo, hanno pieno diritto. Sotto questa visuale, possiamo dire che egli impegnò la Madonna – come appare davvero qui la Madre della Chiesa! – a pagare le "sue cambiali". Accettò le offerte che gli venivano, note ed ignote, come inviate dalla Madonna, messaggeri… una moltitudine di cuori generosi. Egli era l’uomo della fede grande, come la chiede Gesù a tutti nel Vangelo. Iddio gli fece una richiesta, impegnativa ed ardua per mezzo della Madonna, ed egli ripete, con la fermezza di un credo, le parole della Vergine: Fiat! Sono il tuo servo, prendimi in parola. Il pietista si scopre facilmente, e non saprà mai costruire la sua casa spirituale, non saprà mai innalzare un canto. Bartolo Longo, anche quando pare che l’amore per la Vergine e la sua natura esuberante gli prendano la mano, sa controllarsi ed ama essere controllato e "revisionato" da chi ne sa più di lui. E corre a consultare i migliori teologi, e ragiona con essi, come faceva Santa Teresa di Gesù. Consulta storici e persino letterati, perché amava le bellezze della nostra lingua. Anche questa doveva concorrere a fare amare il santo Rosario e l’Opera Pompeiana. C’era in lui la vocazione nativa primigenia al culto delle lettere. Tuttavia il suo entusiasmo religioso, esplodente quanto, è sempre contenuto e diventa mistica contemplazione. Ogni sua preghiera ha una duplice finalità: onorare la Madre di Dio, esaltandone le speciali prerogative, ed offrire a tutti i devoti una guida in questo canto di esaltazione. Il Rosario nella sua anima contiene una speranza luminosa, quasi cosmica, un appello alla vera libertà, che è "la fratellanza universale".
Il Rosario fu il problema di fondo della sua attività religiosa e sociale, giammai una "devozioncella". Il Rosario, si sa, è facile ed alla portata di tutti, ma è anche difficile, e bisogna saperlo intendere, se non si vuole cadere in una fredda ripetizione di Ave Marie.
Il Rosario è conoscenza amorosa di Dio e della Madonna, per quello che Essa è nella storia della salvezza, compiuta dal Cristo. Essa è la sua Madre, in quanto Uomo.
Spiegare lo stretto rapporto tra Gesù, Sapienza incarnata, e Maria, sede della Sapienza, ed idealmente presente fin dalla eternità nello stesso decreto divino che stabilì la redenzione,… impegnò la mente, il cuore, la vita tutta di questa grande anima.. Tale struttura teologica hanno tutte le sue preghiere. Egli vede la Madonna come l’anello di congiunzione, il punto d’incontro tra cielo e terra. Il Magistero solenne ed ordinario della Chiesa ha dato un rilievo non indifferente alla teologia mariana. Oggi i pellegrinaggi che spingono le folle più numerose, puntano verso i Santuari mariani: Loudes, Fatima, Siracusa, POMPEI! Illumina l’Opera e la figura di Bartolo Longo la puntualizzazione di René Laurentin, uno dei più esperti mariologi e voce autorevole del Concilio Vaticano II: "La Vergine è fondamentalmente colei per la quale si è realizzata quaggiù, nel seno della comunità, bisognosa di salvezza, l’Incarnazione dell’Amore, nel senso delle parole di San Giovanni: "Dio è Amore" (Giov. IV, 16). Preghiera e devozione mariana devono dunque sfociare in una incarnazione dell’Amore in modo che esso prenda corpo nella vita concreta, nella piena realtà umana ed ecclesiale, secondo lo spirito del "Fiat" di Maria, e secondo l’invito discreto: "fate tutto ciò che Egli vi dirà". (Giov. II,5)". Questo cercò di apprendere, prima per sé, e poi spiegare agli altri, a tutti i devoti, con vivacità di colori Bartolo Longo. (Parvus)
Preghiera alla Vergine nel mese a Lei consacrato
O santissima ed immacolatissima Vergine,
Madre del mio Dio, Regina di luce,
potentissima e piena di carità, che siedi
incoronata su di un Trono di gloria eretto
dalla pietà dei figli tuoi sulla terra di Pompei;
Tu sei l’Aurora precorrotrice del Sole divino
Nella buia notte delle iniquità che involge il
Nostro secolo. Tu sei la Stella mattutina,
bella, risplendente, il cui splendore sfavillante
s’innalza verso il cielo, penetra nell’inferno, e,
diffondendosi sulla terra, rischiara
l’universo, riscalda i cuori più gelidi, e i morti
nel peccato risuscita alla grazia. Tu sei la
Stella del mare apparsa nella Valle di Pompei
Per la comune salvezza nel quasi universale
Naufragio che han fatto le anime nella fede di
Gesù Cristo. Lascia dunque che io t’invochi
Con questo titolo a Te sì caro di Regina del
Rosario nella Valle di Pompei.
O santa Signora, che sei tutta la speranza
Dei Padri antichi, la gloria dei Profeti, la luce
Degli Apostoli, l’onore dei Martiri, la corona
Delle Vergini, la gioia dei Santi, ricevimi e
Conservami sotto le ali della tua carità e sotto
l’ombra della tua protezione. Abbi pietà di
me, che sono un miserabile peccatore,
macchiato di una infinità di peccati, coi quali
ho offeso Gesù Cristo tuo Figlio, mio
Giudice e mio Dio. O Vergine piena di grazia,
salvami, salvami. Illumina il mio intelletto;
mettimi in bocca delle parole che a Te
piacciono affinchè con tutto l’affetto del mio
cuore io canti le tue lodi sempre, e ti saluti per
tutto questo mese del tuo Rosario consacrato,
come ti salutò l’Angelo Gabriele, quando ti
disse: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.
E dica con lo stesso spirito e con la stessa
tenerezza di Elisabetta: Tu sei benedetta fra
Tutte le donne.
Mia pietosa Madre Regina, per quanto
ami il Santuario di Pompei, che sorge a gloria
del tuo Rosario, per quanto amore porti al
divin tuo Figlio Gesù Cristo, che ti volle
partecipe dei suoi dolori sulla terra e dei suoi
trionfi in cielo, impetrami da Dio le grazie che
tanto desidero per me e per tutti i miei fratelli
e sorelle se esse sono di gloria tua e di salvezza
Alla Vergine del Rosario di Pompei per impetrare il suo amore e il suo patrocinio in vita e in morte.
O Maria, Madre Immacolata di Gesù e
Madre mia dolcissima, Regina del santo
Rosario, Tu che ai giorni nostri ti sei
Degnata di scegliere a tua dimora la Valle
Desolata di Pompei, qual novella Sionne,
donde i popoli irraggi della luce delle grazie
e delle misericordie tue; deh! Volgi verso di
me i tuoi occhi pietosi, e me riconosci tuo
servo e figliuolo che te ama, e a te grida:
Madre di misericordia!
Accorri benigna ai miei gemiti, ai miei
Clamori: i passi tuoi immacolati mi
Apriranno il sentiero della purezza e della
pace.
Suoni alle mie orecchie la tua soavissima
Voce, o dolce Signora mia, perché
Tu non hai che parole di vita.
Apri le tue mani di grazie, e il tuo servo
In degnissimo, che te chiama, aiuta
Perdonando; e scampalo ognora dalle
Insidie dei suoi nemici.
Stendi sino a me quelle dolci catene della tua
Corona, con le quali avvinci i cuori più duri;
e il cuor mio ribelle stringi a te, sì che da te
più non si parta.
O Rosa di
Inviolata purezza, con la fragranza dei tuoi
Verginali profumi traimi all’amore del
Paradiso.
O cara Rosa del Signore, io sospiro a te di
Amore e di dolore.
Deh!, inteneriscimi col tuo pianto:
compungimi con la tua compassione;
trafiggimi coi tuoi dolori; rinvigoriscimi con
la tua grazia.
O Maria Madre di grazia, prega per me.
Prendi me per tuo servo.
Fa che io sempre confidi in te; sempre io
Pensi a te; sempre io chiami te; sempre io
Serva te; sempre io ami te. Per te io viva, per
Te io operi, per te patisca, per te muoia.
E nell’ora della morte liberami dal demonio
e conducimi per mano a Gesù tuo Figliuolo
e mio Giudice.
O Cuore Immacolato della Madre di Dio,
fonte inesausta di bontà, di dolcezza, di
amore e di misericordia, ricevi il mio cuore.
Rendilo simile al tuo, purificalo con la tua
Intercessione: santificalo col tuo amore:
distaccalo dall’amore delle creature. E quel
fuoco divino che accende il tuo Cuore,
accenda puranco il mio nel tempo e
nell’eternità. Così sia!
Bartolo Longo, in “Raccolta delle preghiere alla Vergine del Rosario di Pompei”, 216 s, Valle di Pompei 1894.
O Maria, O vergine clemente delle rose eterne, o Regina invitta delle Vittorie. Tu vedi in quante guise è combattuto ed oppresso in questo secolo l’Ordine a te sì caro del tuo prediletto figliuolo Domenico. Deh, per quella onnipotenza che ti ha posto in mano il tuo Figliuolo Dio; con quell’amore di madre che sempre hai portato a’ figli dell’Ordine tuo favorito; segna oggi l’ora del risorgimento di esso alla primitiva grandezza e santità sua: oggi, che la tua grandezza e clemenza fai risplendere allo sguardo di tutte le genti per mezzo del prodigioso tuo Santuario di Pompei. Incominci oggi il tuo trionfo da questo mio cuore indurito, e poi nei cuori di tutti coloro cui capiterà questo libretto; acciocchè tutti abbiano la sorte di arrolarsi in terra tra le schiere del tuo Terz’Ordine Domenicano, raccolti sotto il manto delle tue misericordie, e sieno in cielo annoverati tra le schiere de’ tuoi lodatori eterni. Ma non isdegnare ora di volgere lo sguardo di compassione al più indegno de’ tuoi figli, allo sciagurato peccatore, il quale in te sola, dopo Dio, ha posto ogni sua speranza.
Avv. Bartolo Longo
Col nome di Fra Rosario nel Terz’Ordine
della Penitenza di S. Domenico.
*Rosario e Eucaristia: il Cielo e la terra!
Due straordinari scritti di Bartolo Longo
(Due testi attinti al prezioso e incomparabile scrigno degli scritti del Beato Bartolo Longo)
Due trilogie, Betlem, il Calvario, il Cielo
La Provvidenza qui ha voluto che il risveglio eucaristico avvenisse soprattutto per mezzo del Rosario.
Quale segreta relazione vi è fra il Rosario e l’Eucarestia?
Il Rosario è il Vangelo ridotto a un poema di tre cantiche. Nel meditare la Corona ogni anima fervente canta un triplice inno: essa canta la vita di Gesù e di Maria ne’ gaudii, ne’ dolori, ne’ trionfi. Ora ne’ vasti firmamenti della preghiera questi tre gruppi di misteri sono come tre sistemi planetarii, che girano ciascuno intorno a un grande centro.
Osservate il sistema planetario de’ Misteri gaudiosi: il suo centro è Betlem. L’Annunciazione, la scena segreta e delicata che ispirerà alla patristica sublimi commenti che fiorirà come la più leggiadra rosa dell’arte sotto il pennello e lo scalpello degli artisti del Medio Evo, l’Annunciazione non è che un prologo; un prologo è pure la Visita di Maria ad Elisabetta, come nella musica della Provvidenza il Magnificat non è che la meravigliosa sinfonia del Gloria in excelsis. Similmente la Purificazione è il Bambino di Betlem, la cui oscurità è irradiata d’un tratto da una gran luce di profezia; come la Disputa fra’ Dottori è quel medesimo Bambino, divenuto appena adolescente, che da se stesso rischiara il mistero del suo silenzio, rivelandosi di fronte all’Ebraismo come la sapienza di Dio Padre.
Osservate ancora il sistema planetario de’ Misteri dolorosi: il suo centro è il Golgota. In questa seconda parte della mariana trilogia si canta il Divino Sacrifizio. I Misteri dolorosi sono una Via Crucis ridotta, una Via crucis a cinque stazioni, e il punto d’arrivo è il Calvario. La mente vi giunga dopo aver pellegrinato dal Getsemani, attraverso scene di tristezza, di umiliazioni, di crudeli spasimi, scene che le hanno ispirato tenerezza, gratitudine, compunzione; e l’anima giunta sulla funebre spianata, senza stanchezza ma bisognosa di mistico riposo, si ferma a’ piedi della Croce, e satibonda di perdono accoglie le stille del prezioso Sangue.
Considerate finalmente il sistema planetario de’ Misteri gloriosi: il suo centro è il Cielo. In questa terza cantica s’inneggia alla glorificazione degli eletti. Gesù risorge, vestito di luce e di bellezza: trionfatore della morte, Egli comunicherà a’ redenti la forza di un’eterna vita. Ascende pei cieli tersi, in que’ cieli ove non si solleva ne’ la vista del telescopio ne’ la vista del genio; dopo di lui in fulgide liste ascendono venerandi Patriarchi e ispirati Profeti: il peccato aveva chiuso le porte del Paradiso, le spalanca a tutti gli uomini l’universale Redenzione.
Per conquistare però il Cielo, che è un premio sopra la natura, sono necessarie opere egualmente soprannaturali; lo Spirito Santo discende sulla terra per essere la forza della nostra debolezza; Egli ci pone nel cuore la grazia, il seme dell’eterna gloria.
Ebbene, come il Rosario, così l’Eucarestia è un ricordo perenne della vita di Gesù. Nell’istituzione del Divin Sacramento Gesù ha detto: - Voi farete questo in memoria di me. – Con queste brevi semplici parole Gesù ha abolito d’un tratto l’antico culto ebraico e l’ha sostituito col nuovo culto cristiano, di cui vita e centro è il Santissimo Sacramento: il culto antico era simbolico, il culto nuovo è commemorativo; il culto antico era tutto una profezia, il culto nuovo è tutto un’epopea.
La misteriosa vita di Gesù nel Sacramento ricorda tutta la vita di lui in mezzo agli uomini, dall’Arcangelo che l’annunzia a Nazareth fino al termine della suo opera redentrice, che è la consumazione degli eletti nell’eterno gaudio e nell’eterna pace; particolarmente però la vita di Gesù nel Santissimo Sacramento è una meravigliosa trilogia: Betlem, il Calvario, il Cielo.
L’Eucarestia è una piccola Betlem. Vi è lo stesso silenzio, la stessa povertà, la stessa reiezione; Gesù qui si impiccolisce anche più che a Betlem, restringendosi, a nostro modo di intendere, negli angusti limiti d’un ostia.
Le sacre Specie, quelle Specie tenui e bianche, fanno pensare a’ candidi pannolini, in cui il Divin Infante fu avvolto dalle mani santissime della più eletta fra le Vergini. Il tabernacolo non ricorda il santo Speco? E dal tabernacolo si solleva lo stesso inno di Betlem, l’inno di gloria e di pace. In nessun punto del mondo Dio è glorificato come in un tabernacolo eucaristico. E come da ogni tabernacolo viene gloria a Dio, così di là agli uomini viene la pace: Ciascuno di questi tabernacoli è un porto delle anime, un porto in cui il cuore, gettata l’ancora della fede, riposa sicuro lungi dalla tempesta degli affanni e delle passioni.
Ancora, l’Eucarestia è un Calvario perenne. Tutti gli Altari sono una Croce, tutte le Messe sono un Sacrificio. Il Corpo di Gesù, presentandosi, all’apparenza, diviso nel suo Sangue, ci ricorda a vivo le strazianti effusioni della giornata redentrice. Sì, ecco il Corpo esangue del Golgota! Ecco il Sangue per noi tutto raccolto, raccolto fino all’ultima stilla nel calice della giustizia.
L’Apostolo Paolo scriveva a’ primi fedeli: Sempre che voi mangerete di questo pane e beverete di questo Calice, annunzierete la morte del Signore. Gesù nell’Eucarestia s’immola tutto, con divina liberalità, con divina profusione propriamente come sul Golgota; sacrifica non solo gli splendori della sua Divinità, ma le grazie della sua Umanità, il maestoso decoro della sua fronte, la mesta dolcezza del suo sguardo, quella sua beltà esteriore, più spirituale come corporea, perfino la libertà de’ suoi movimenti, perfino l’armoniosa sapienza della sua parola, perfino la figura medesima di uomo.
Infine l’Eucarestia è il Cielo sulla terra. Essa è un saggio del Paradiso, dato a chi trovasi ancora nella dura condizione di dolore, Dio che si comunica nell’anima – ecco il Cielo. Dio che si comunica all’anima – ecco pure l’Eucarestia. Oh, la Mensa Eucaristica! Che pace anche negli uragani più violenti della vita! Che dolcezza anche nelle ore più sconfortate dell’affanno! Così è il pegno della futura gloria – canta la poesia della Chiesa. Il glorioso protomartire Santo Stefano soffriva con gli occhi rivolti al Cielo: innumerevoli Martiri dopo di lui hanno sofferto avendo il Cielo nella loro anima, perché prima di andare al martirio, erano andati a ricevere la Comunione.
L’Eucarestia e il Rosario entrambi sono un ricordo della vita di Gesù, entrambi sono una meravigliosa trilogia: Betlem, il Calvario, il Cielo.
Ciò che è il Rosario nell’ordine soggettivo o ideale, è pure l’Eucarestia nell’ordine oggettivo e reale. Nel Rosario è la vita di Gesù che si ripete idealmente nella pia meditazione di chi prega; nell’Eucaristia è la vita di Gesù che si ripete realmente in Gesù medesimo, perché Egli viene sull’Altare per ritrovarvi la sua Betlem, per riabbracciarvi la sua Croce, per dare alle anime un preludio del Cielo.
Il progresso della pietà cattolica nell’epoca contemporanea
… Ecco dunque il procedimento della pietà cattolica nell’epoca contemporanea: la Provvidenza ha voluto che si ridestasse ne’ popoli la divozione del Rosario, per ridestare poi ne’ popoli la divozione del Santissimo Sacramento. È tutta una primavera di mistiche rose che fiorisce nelle aiuole di Maria, ma la celeste Madre educa queste rose per gli Altari del Figlio suo.
Ed ecco seguirsi l’un l’altro immediatamente due Papi: Leone XIII, il Papa del Rosario, Pio X, il Papa dell’Eucarestia. Oh, com’è ammirabile la Provvidenza! Leone XIII chiama tutte le genti a recitare la Santa Corona con ben 15 encicliche, che rappresentano uno de’ monumenti più insigni della sua sapienza pontificale, e, quasi direi, la Somma Teologica del Rosario.
Pio X chiama le genti all’Eucaristia: Egli promuove la Comunione de’ fanciulli, la Comunione degli infermi, la Comunione frequente, agevola l’amministrazione del Viatico, da’ il più forte impulso a’ Congressi eucaristici.
Leone XIII vuole il Rosario quotidiano, Pio vuole la Comunione quotidiana. Due opere in apparenza separate, in realtà congiunte da invisibili fili d’oro, i fili arcani della divina Provvidenza!
Fratelli, nell’amore della benedetta Vergine di Pompei, andiamo dunque spesso, anche tutti i giorni, a quell’Altare che dovrebbe essere la Mensa degli Angioli, e che solo un prodigio della divina carità ha potuto fare la Mensa degli uomini. Voi che tutti i giorni meditate la vita di Gesù nella recita della Corona, andate ad attingere questa vita nella sua sorgente, andate anzi a riviverla insieme con Gesù nelle intime misteriose effusioni dell’amplesso eucaristico. Magister adest et vocat te! Il Maestro è qui in tutti i tabernacoli del mondo, Egli richiama con tante voci quanti sono i Misteri del Rosario, quante sono le ispirazioni che in ciascun Mistero vi da’ Maria. Volete frequenti le grazie? Fate frequente la Comunione; quando Maria avrà posto Gesù nel vostro cuore. Quando Egli sarà in voi e con voi, come mai potrebbe non esaudirvi?
Col Rosario nella mano, con l’Eucaristia nel cuore, voi sarete i cittadini nel Cielo, pur essendo ancora gli abitatori della terra; voi sarete i fratelli degli angioli, pur vivendo ancora con gli uomini; voi, distruggendo al fuoco della fede, della pietà e dell’amore i vostri difetti e le vostre passioni, diverrete uomini celesti, uomini divini.
(Avv. Bartolo Longo – da Il Rosario e l’Eucaristia, in "Il Rosario e la Nuova Pompei", 1914, pp. 241-250)
(Autore: Pasquale Mocerino)
*Sant'Apollonia una donna forte in un testo del Beato Bartolo Longo
La
(Autore: Luigi Leone Pompei 8 Maggio 2004)